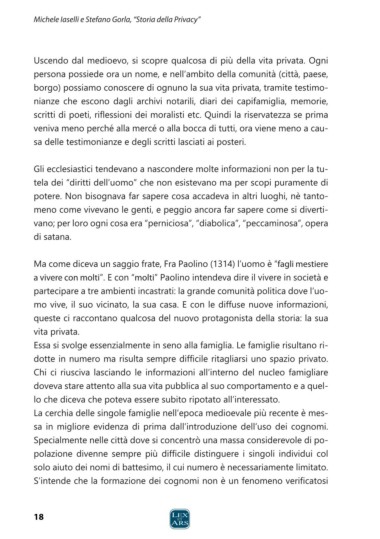Page 18 - STORIA_della_PRIVACY
P. 18
Michele Iaselli e Stefano Gorla, “Storia della Privacy”
Uscendo dal medioevo, si scopre qualcosa di più della vita privata. Ogni
persona possiede ora un nome, e nell’ambito della comunità (città, paese,
borgo) possiamo conoscere di ognuno la sua vita privata, tramite testimo-
nianze che escono dagli archivi notarili, diari dei capifamiglia, memorie,
scritti di poeti, riflessioni dei moralisti etc. Quindi la riservatezza se prima
veniva meno perché alla mercé o alla bocca di tutti, ora viene meno a cau-
sa delle testimonianze e degli scritti lasciati ai posteri.
Gli ecclesiastici tendevano a nascondere molte informazioni non per la tu-
tela dei “diritti dell’uomo” che non esistevano ma per scopi puramente di
potere. Non bisognava far sapere cosa accadeva in altri luoghi, nè tanto-
meno come vivevano le genti, e peggio ancora far sapere come si diverti-
vano; per loro ogni cosa era “perniciosa”, “diabolica”, “peccaminosa”, opera
di satana.
Ma come diceva un saggio frate, Fra Paolino (1314) l’uomo è “fagli mestiere
a vivere con molti”. E con “molti” Paolino intendeva dire il vivere in società e
partecipare a tre ambienti incastrati: la grande comunità politica dove l’uo-
mo vive, il suo vicinato, la sua casa. E con le diffuse nuove informazioni,
queste ci raccontano qualcosa del nuovo protagonista della storia: la sua
vita privata.
Essa si svolge essenzialmente in seno alla famiglia. Le famiglie risultano ri-
dotte in numero ma risulta sempre difficile ritagliarsi uno spazio privato.
Chi ci riusciva lasciando le informazioni all’interno del nucleo famigliare
doveva stare attento alla sua vita pubblica al suo comportamento e a quel-
lo che diceva che poteva essere subito ripotato all’interessato.
La cerchia delle singole famiglie nell’epoca medioevale più recente è mes-
sa in migliore evidenza di prima dall’introduzione dell’uso dei cognomi.
Specialmente nelle città dove si concentrò una massa considerevole di po-
polazione divenne sempre più difficile distinguere i singoli individui col
solo aiuto dei nomi di battesimo, il cui numero è necessariamente limitato.
S’intende che la formazione dei cognomi non è un fenomeno verificatosi
18 ALEERTXS